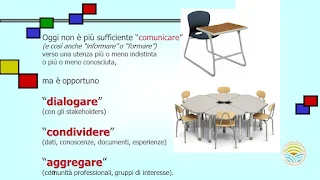PSR 2014-2022 SICILIA MISURA 16.1
GO:
Capofila: Consorzio per la Tutela della Ciliegia dell’Etna DOP
email: info@ciliegiaetnadop.it tel: tel:335.6964720
Coordinatore: Alberto Continella
email: alberto.continella@unict.it tel: 338.6570736
Imprese agricole:
Case Perrotta Srl
- FondoAranci di Enrico Cutuli
- Il Ciliegio dell'Etna Srl
- La Gelsomina
Ricerca:
- CSEI Catania
Università:
- Università degli Studi di Catania
Altri:
- La Fenice Srl
- I Peccatucci di Mamma Andrea Srl
Data inizio progetto 28/07/2020 e fine 30/07/2023
Qual è la sfida o il problema pratico che il gruppo operativo sta affrontando o quale opportunità sta affrontando?
L’obiettivo generale del progetto è di rafforzare la filiera della Ciliegia DOP dell’Etna mediante l’introduzione di innovazioni, e supportare la realtà produttiva del ciliegio, con lo scopo di realizzare un percorso di conoscenza: dalle caratteristiche agronomiche alle peculiarità qualitative. Sono stati affrontati diversi aspetti della filiera: dalla selezione di un clone della varietà DOP‘Mastrantonio, alla produzione in campo con tecniche economicamente ed ecologicamente sostenibili, dalla scelta del portinnesto più idoneo al controllo sostenibile dei due insetti carpofagi delle ciliegie, Ragholetis cerasi e Drosophila suzukii, fino alla gestione post-raccolta della ciliegia e all’individuazione di nuovi prodotti trasformati. Oggi si osserva sul territorio etneo la presenza di cloni della varietà ‘Mastrantonio’. Al fine di superare la difformità genetica del materiale di propagazione, durante lo svolgimento del progetto è stato selezionato il clone con le migliori caratteristiche vegeto-produttive. Pertanto è stato costituito un campo di piante madri di‘Mastrantonio’per la sua diffusione sul territorio assicurando omogeneità ed elevata qualità alle produzioni cerasicole locali. Il materiale è stato preventivamente saggiato dal punto di vista fitopatologico per propagare e fornire agli agricoltori materiale sano.
Per far fronte alle problematiche legate all’orografia che contraddistingue l’areale di coltivazione del ciliegio etneo, durante lo svolgimento del progetto sono stati introdotti portinnesti innovativi per ridurre l’habitus vegetativo delle piante. Sono stati istituiti impianti con le varietà di maggiore pregio (autoctone e alloctone che presentano caratteri fenologici, pomologici e qualitativi di rilievo) innestate su portinnesti selezionati per le loro caratteristiche, soprattutto con riferimento alla vigoria. L’influenza del portinnesto sulle caratteristiche vegeto-produttive e qualitative è stato studiato per tutta la durata del progetto.
Un altro obiettivo del progetto è stato il trasferimento di strategie e tecniche di irrigazione di precisione per produrre con ridotti consumi idrici frutti ad elevata qualità. Sono state trasferite alle imprese indicazioni al fine di eliminare o ridurre al minimo gli effetti indesiderati di contaminazione del suolo e dovuti all’utilizzo degli insetticidi di sintesi ad ampio spettro d’azione e scarsa capacità di degradazione. Questi erano utilizzati per combattere la mosca del ciliegio (Rhagoletis cerasi), che ovidepone sulle drupe all’inizio dell’invaiatura determinando rammollimento e marciume del tessuto dei frutti. Dal 2013 ad oggi, il dittero asiatico Drosophila suzukii, chiamato anche moscerino dei piccoli frutti, è diventato il principale problema fitosanitario di questa coltura. Un altro obiettivo del progetto è stato il trasferimento agli agricoltori delle innovazioni, tra cui i lanci di un insetto antagonista, Ganaspis brasiliensis, per il controllo sostenibile della Drosophila suzukii.
Qual è la soluzione, la pratica, il prodotto, il processo concreto e innovativo sviluppato dal vostro OG per affrontare la sfida o cogliere l'opportunità?
Le innovazioni introdotte riguardano una maggiore conoscenza delle risorse genetiche autoctone e delle tecniche agronomiche, tra cui l’utilizzo di portinnesti innovativi, per gestire la coltivazione ed esaltare le caratteristiche qualitative. Un campo di piante madri della ‘Mastrantonio’ è stato istituito al fine di selezionare e diffondere materiale geneticamente omogeneo e esente da problematiche fitopatologiche. Il ciliegio dolce è una pianta caratterizzata da una forte dominanza apicale e un’eccessiva vigoria, una tardiva epoca di messa a frutto e una raccolta laboriosa. Tutti questi fattori concorrono a determinare costi produttivi elevati. Per ovviare questa problematica, sono stati introdotti portinnesti innovativi a ridotta vigoria che riducono il periodo giovanile ed improduttivo e consentono la produzione di campi ad alta e media densità.
Nel contesto del cambiamento climatico, sono stati realizzati degli impianti di irrigazione a bassissima pressione e on-line scelti per tener conto delle esigenze idriche delle colture ed anche delle caratteristiche plano-altimetriche dei ciliegeti in esame. L’obiettivo è stato la diffusione di nuove tecniche di irrigazione che consentano l’ottenimento di prodotti ad elevata qualità con ridotti apporti irrigui.
Ai fini di una ottimale commercializzazione del prodotto, sono state messe a punto e applicate idonee tecnologie di condizionamento per il prolungamento della shelf-life in post-raccolta e sono state inoltre sviluppate alcune attività di produzione di trasformati della ciliegia. Nel dettaglio, sono state utilizzate tecniche innovative di IV gamma al fine di individuare il confezionamento migliore e di aumentare le caratteristiche qualitative del prodotto fresco.
Per quanto concerne le avversità biotiche, sono stati effettuati interventi di monitoraggio per la realizzazione di protocolli per il controllo sostenibile della Rhagoletis cerasi e della Drosophila suzuki. Presso quattro aziende partner del progetto ubicate nell’areale cerasicolo etneo, sono stati monitorati due ditteri carpofagi dall’inizio di maggio fino al periodo di raccolta delle ciliegie mediante sostituzione settimanale di trappole attivate con attrattivo alimentare. Questa tecnica innovativa ha consentito di associare la ridotta presenza del fitofago alla quasi assenza di danni ai frutti.
In che modo i professionisti sono stati coinvolti nello sviluppo della soluzione, della pratica, del processo o del prodotto?
Il progetto ha consentito il trasferimento di diverse innovazioni nella filiera cerasicola fornendo conoscenze alle aziende partner di progetto, e ai produttori locali e nazionali, sulle pratiche agronomiche, sulla lotta biologica e sulle tecniche di conservazione in IV gamma. Determinante in tal senso è stato il ruolo del capofila del progetto, il Consorzio per la tutela della ciliegia dell’Etna DOP che si prefigge di sostenere e promuovere le conoscenze dei cerasicoltori anche attraverso la ricerca e la sperimentazione.
Sono state effettuate prove di irrigazione deficitaria in tre aziende agricole in cui sono stati realizzati impianti che vengono modulati in base alle esigenze idriche delle colture ed anche delle caratteristiche plano-altimetriche dei ciliegeti in esame.
Sono stati progettati e realizzati tre campi dimostrativi presso tre aziende partner le quali si sono occupate della gestione agronomica ordinaria. L’obiettivo è stato trasferire agli agricoltori le conoscenze sul comportamento
dei portinnesti e delle varietà selezionate in condizioni ambientali diverse. La opportunità della realizzazione di campi dimostrativi in tre ambienti è data dalla esigenza di comprendere la risposta delle diverse combinazioni nesto/portinnesto selezionate al soddisfacimento del fabbisogno in freddo nei tre contesti territoriali, anche in virtù del cambiamento climatico in atto.
Presso le tre aziende partner è stata effettuata la lotta biologica attraverso il posizionamento di trappole in campo e trattamenti con bioinsetticidi. Inoltre è stata coinvolta una azienda di trasformazione per poter valorizzare la frutta mediante il conseguimento di confetture di elevato pregio organolettico e nutraceutico.
Come avete diffuso i risultati del progetto al di fuori del progetto?
I risultati del progetto sono stati divulgati attraverso webinar, social media, convegni e congressi nazionali in cui sono state presentate le problematiche legate alla coltivazione cerasicola etnea, gli obiettivi del progetto e le innovazioni di processo e di prodotto che sono state attuate ed introdotte nei diversi campi dimostrativi.
Atti di convegno:
- La Spada P., Modica G., Siracusa L., Strano T., Gentile A., Continella A. 2023. Effetti del portinnesto sulle caratteristiche pomologiche, qualitative e nutraceutiche di due varietà di ciliegio dolce. XIV Giornate Scientifiche SOI. Torino (Italia), 21-23 Giugno 2023.
- Lisi, F., Biondi, A., Cavallaro, C., Zappalà, L., Campo, G., Roversi, P.F., Sabbatini Peverieri, G., Giovannini, L., Tavella, L., Tortorici, F., Bardella, S., Carli, C., Bosio, G., Mori, N., Tonina, L., Zanini, G., Caruso, S., Vaccari, G., Masetti, A., Bittau, B., Bariselli, M., Schmidt, S., Falagiarda, M., Bertignono, L., Bonfanti, R., Giorgini, M., Guerrieri, E., Tropiano, F.G., Verrastro, V. and Baser, N. (2022). Current status of Drosophila suzukii classical biological control in Italy. Acta Hortic. 1354, 193-200 DOI: 10.17660/ActaHortic.2022.1354.25
- Rizzo V., Celano F., Sorci P., Barbagallo S., Muratore G. (2021) “Comparison and Consumer’s Preference on Jam and Jelly from “Mastrantonio” Sweet Cherry Fruits”. in Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Foods - "Future Foods and Food Technologies for a Sustainable World", 15–30 October 2021, MDPI: Basel, Switzerland, Biology and Life Sciences Forum, 6, 1: 35. (EISSN 2673-9976). https://doi.org/10.3390/Foods2021-10990.
- Rizzo V., La Spada P., Continella A., Barbagallo S., Muratore G. (2022) “Shelf life Assessment of Sweet Cherry “Ciliegia dell’Etna – cv. Mastrantonio” Influenced by Different Packaging Materials", “Shelf Life International Meeting 2022 (SLIM 2022)”, Bogotà (Colombia), 28 Nov. – 1 Dec. 2022. Book of abstracts, p. 68
Libro:
Innovazioni sostenibili per il miglioramento della ciliegia dell’Etna, S. Barbagallo, A. Gentile. Catania: CSEI, 2023.
Quali sono stati i risultati concreti ottenuti attraverso queste attività di diffusione?
Il progetto ha centrato l’obiettivo generale di rafforzare la filiera della Ciliegia DOP dell’Etna mediante l’introduzione di innovazioni studiate e messe a punto negli anni passati dall’Università di Catania. A tal proposito i prossimi impianti potranno usufruire del campo di piante madri di‘Mastrantonio’per il prelievo del materiale vegetale e la propagazione di materiale sano e geneticamente omogeneo. I nuovi impianti potranno godere delle conoscenze sul comportamento dei portinnesti nanizzanti per contenere l’habitus vegetativo e ridurre i costi di raccolta.
Trasferibilità, scalabilità e creazione di valore di mercato dei risultati innovativi.
Trasferibilità
I risultati sono trasferibili in diversi contesti pedoclimatici e altimetrici poiché sono state individuate, studiate e selezionate cultivar particolarmente differenti in termini di calendario di maturazione, che viene intercettato interamente ed ulteriormente ampliato in virtù del gradiente altitudinale del territorio investito a questa coltura. Le analisi eseguite su questo germoplasma etneo hanno permesso di apprezzare le ampie e spesso ragguardevoli caratteristiche pomologiche ed organolettiche delle diverse varietà.
La lotta biologica effettuata presso le aziende del territorio etneo è trasferibile in altri contesti in particolare per limitare la diffusione delle due avversità entomologiche, Ragholetis cerasi e Drosophila suzukii. Anche l’utilizzo di tecniche agronomiche innovative, quali i portinnesti, e la produzione di frutta fresca in IV gamma sono risultati replicabili in altre realtà.
Scalabilità
Potrebbero essere realizzati campi con maggiori combinazioni di innesto al fine di studiare l’influenza del soggetto sulle caratteristiche vegeto-produttive e qualitative dei frutti.
La lotta biologica dovrebbe essere applicata in scala più ampia in modo da poter monitorare meglio la diffusione di Ragholetis cerasi e di Drosophila suzukii ed effettuare trattamenti con bioinsetticidi.
Creazione di valore di mercato
La specializzazione degli impianti risulta importante per il rilancio del settore: l’elevata vigoria che conferisce il franco come portinnesto e i notevoli costi di raccolta e potatura conseguenziali hanno reso nel tempo necessario la valutazione di nuovi portinnesti in grado di contenere lo sviluppo della chioma e rendere economicamente sostenibile la coltivazione del ciliegio in tali areali. Gli studi effettuati sulle diverse combinazioni di innesto hanno evidenziato un miglioramento nel gusto, nel colore della buccia e della polpa, nella consistenza e nella dimensione.
L’analisi dei frutti in post-raccolta ha consentito di individuare un materiale film BIO ad alta barriera biodegradabile a base di cellulosa che ha influito in modo significativo sulla qualità post-raccolta della ciliegia dolce.
Attraverso la realizzazione di impianti pilota, sono state trasferite le conoscenze al comparto circa l’utilizzo della tecnica di micro-irrigazione per ottenere adeguati risparmi idrici e incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua da parte delle colture.
I lanci di un insetto antagonista, il Ganaspis brasiliensis, per il controllo sostenibile della Drosophila suzukii, parassita che ha danneggiato in modo rilevante le produzioni degli ultimi anni, appare promettente per la risoluzione di questo problema.